7 settembre 2008
Ieri ho tenuto la lezione conclusiva di un Corso di formazione nazionale di sette giorni, organizzato dall’Associazione Educatori Senza Frontiere, presso la Foresteria dell’Abbazia di Montecassino, per giovani interessati a fare l’esperienza educativa del rapporto con l’estero. Mi era stato assegnato il tema: Spirito, stili e forme nell’utopia dell’Avamposto.
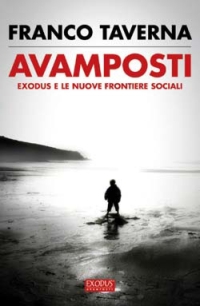 Al di là e oltre gli argomenti tipici di Exodus – a partire dalla teorizzazione avviata nel 2005 da don Antonio Mazzi -, ho utilizzato Chatwin, Attali, Magris, oscillando tra Estetica e Letteratura, come ho sempre fatto. Ho distribuito per i 24 Corsisti i miei materiali, come ero abituato a fare a Scuola. La lezione deve essere seguita bene. Una lista delle idee alla lavagna o una mappa mentale aiutano a partire. Se si riesce a produrre anche una mappa concettuale, ancora meglio! Ho indicato i termini tecnici, le parole-tema, le categorie concettuali. Ho anticipato tutto il contenuto della mia conversazione. Al termine, ho riassunto e sintetizzato per punti. Ho lasciato che i ragazzi si scrivessero i titoli del libri che ho portato con me. Ho lasciato il mio indirizzo di posta elettronica, per continuare la discussione avviata su due o tre temi toccati dai ragazzi stessi. La ‘lezione’, secondo me, doveva servire ad aprire un fronte di ricerca, più che costituire una sintesi chiusa su un concetto e basta.
Al di là e oltre gli argomenti tipici di Exodus – a partire dalla teorizzazione avviata nel 2005 da don Antonio Mazzi -, ho utilizzato Chatwin, Attali, Magris, oscillando tra Estetica e Letteratura, come ho sempre fatto. Ho distribuito per i 24 Corsisti i miei materiali, come ero abituato a fare a Scuola. La lezione deve essere seguita bene. Una lista delle idee alla lavagna o una mappa mentale aiutano a partire. Se si riesce a produrre anche una mappa concettuale, ancora meglio! Ho indicato i termini tecnici, le parole-tema, le categorie concettuali. Ho anticipato tutto il contenuto della mia conversazione. Al termine, ho riassunto e sintetizzato per punti. Ho lasciato che i ragazzi si scrivessero i titoli del libri che ho portato con me. Ho lasciato il mio indirizzo di posta elettronica, per continuare la discussione avviata su due o tre temi toccati dai ragazzi stessi. La ‘lezione’, secondo me, doveva servire ad aprire un fronte di ricerca, più che costituire una sintesi chiusa su un concetto e basta.
Il riferimento all’utopia contenuto nell’argomento del mio intervento non era certo da intendere nel senso delle grandi utopie politiche, come se Exodus avesse da proporre una palingenesi dell’umanità, una generale visione del mondo in competizione con le ideologie politiche. E non ho certo inteso in senso apocalittico il significato della proposta in questione. Al piano di realtà psicologico-sociale e politico occorreva opporre la dimensione esclusivamernte educativa dell’intervento nella realtà del soggetto chiamato Exodus. Ho preso le mosse dalla critica del Moderno che è tipica dei grandi soggetti del nostro tempo. Ho ricordato la critica al Relativismo da parte di Benedetto XVI, ma più in generale la necessità per noi di opporci alle derive culturali del tempo, per spiegare le quali ho accennato al nichilismo, al trionfo della tecnica su ogni attività spirituale dell’uomo e ai nuovi vizi (consumismo, conformismo, spudoratezza, sessomania, sociopatia, diniego, vuoto). Si costituisce come utopia, allora, non tanto un fondo di impossibile che è pure possibile scorgere nelle grandi visioni culturali, quanto la resistenza che si oppone alle derive, la tensione morale che si indica alla gente, perché non subisca mode e costumi riconducibili alla ‘civiltà dell’usa e getta’.
L’utopia dell’avamposto si ripresenta come radicale assunzione di responsabilità degli Educatori tutti (genitori, insegnanti, religiosi, intellettuali, operatori culturali e sociali), perché non rinuncino al coraggio di educare, compito che si qualifica oggi nei termini chiari della critica della civiltà. Essere avamposti significa schierarsi contro le derive culturali e morali, del costume e della mentalità corrente, come delle istituzioni e della società.
Oggi abbiamo a che fare con quello che Attali chiama l’uomo nomade. Conclusa l’epoca in cui ogni genere di esperienza si trasmetteva nei luoghi deputati alla ‘educazione dell’esperienza’ – un tempo si credeva fortemente che si dovesse trasmetterla di generazione in generazione -, assistiamo al proliferare di luoghi e di modi di vivere che individui e gruppi promuovono, in cerca di identità, di radici, di forme di riconoscimento.
Sentinella, a che punto è la notte? è stato il punto di avvio della mia conversazione. Ho aggiunto una parabola ebraica sul confine tra notte e giorno. Ho ricordato le parole di Giovanni Paolo II, a proposito dei giovani, da lui definiti, al termine di un grande raduno, sentinelle del mattino. Ho elencato le figure di cui si serve Galimberti per illustrare il segreto della giovinezza (ad esso bisognerebbe guardare, per oltrepassare il nichilismo, almeno nelle sue catastrofiche ricadute giovanili), in fondo a L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani.: l’espansività, l’assenza, il viaggio, la sfida, la trasformazione, la riappropriazione, la rivelazione di sé a sé. Ho illustrato il ‘passaggio’ dalla “civiltà delle parrocchie” – con la figura del ‘praticante’ – alla dimensione dell’erranza, del viaggiare – con la figura del ‘pellegrino’ -, per dimostrare come anche in ambito religioso si stia affermando una originale forma di nomadismo, per cui la trasmissione dell’esperienza religiosa non si verifica più (prevalentemente) nella parrocchia, come un tempo. Almeno per i giovani, non è più così. Ho letto, per concludere, un brano di Magris dato in fotocopia, sul narrare.
Ho esortato i ragazzi alle storie. La figura dell’agrimensore del reale è stata da me esaltata come via per la quale accedere all’esperienza erratica del viaggio che non è fuga dalla realtà e dalla responsabilità, ma quete incessante e ininterrotta di naviganti “sedotti dal sanguigno piacere dell’esistenza” che, “pervasi da pietas per il suo inarrestabile svanire nel tempo”, “stendono mappe fedeli del cielo e delle coste…”.
La nostra fedeltà al reale fa di noi viandanti credibili. In mezzo a ciò che muta incessantemente intorno a noi, non smettiamo mai di credere che ci sia dell’indistruttibile a cui tendere, da far vivere, da ‘scambiare’ con coloro i quali, a loro volta, sono in cammino, mai stanchi di incontrare nuovi volti e cieli nuovi. Di tutta la vita santa e buona – come direbbe Alce Nero – noi vorremmo salvare ogni grumo, perché niente vada perduto. Di ogni cosa vogliamo raccontare la storia, perché non precipiti nella dimenticanza, senza lasciare alcuna traccia di sé presso di noi.
* * *
Un giorno un vecchio rabbino chiede ai suoi discepoli da quale segno sia possibile riconoscere il momento preciso in cui finisce la notte e comincia il giorno. La domanda dà origine ad un interessante dialogo.
– E’ forse – reagiscono i discepoli – quando si può distinguere da lontano e senza fatica un cane da una pecora?
– No, dice il rabbino. E così avanti nel dialogo.
– Ma quand’è allora? – chiedono i discepoli.
– E il rabbino risponde: E’ quando, sperduto nella folla, il volto di uno sconosciuto qualsiasi vi diventa altrettanto prezioso quanto quello di un padre, di una madre, di un fratello, di una sorella, di un figlio o di una figlia, di uno sposo o di una sposa, di un amico… Fino a quel momento, fa ancora notte nel vostro cuore.
*
«Viaggiare è immorale, diceva Weininger viaggiando; è crudele, incalza Canetti. Immorale è la vanità della fuga, ben nota a Orazio che ammoniva a non cercare di eludere i dolori e gli affanni spronando il cavallo, perché la nera angoscia, dice il suo verso, siede in groppa dietro il cavaliere che spera di farle perdere le proprie tracce. L’io forte, secondo il filosofo viennese presto stroncato dalla convivenza con l’assoluto, deve restare a casa, guardare in faccia angoscia e disperazione senza volerne essere distratto o stordito, non distogliere lo sguardo dalla realtà e dal combattimento; la metafisica è residente, non cerca evasioni né vacanze. Forse talora l’io resta a casa e a viaggiare è un suo sembiante, un simulacro simile a quello di Elena che, secondo una delle versioni del mito, aveva seguito Paride a Troia, mentre la vera Elena sarebbe rimasta, per tutti i lunghi anni della guerra, altrove, in Egitto. Weininger denunciava nel viaggio la tentazione dell’irresponsabilità; chi viaggia è spettatore, non è coinvolto a fondo nella realtà che attraversa, non è colpevole delle brutture, delle infamie e delle tragedie del paese in cui s’inoltra. Non ha fatto lui quelle leggi inique e non ha da rimproverarsi di non averle combattute; se il tetto di una notte crolla ed egli non ha proprio la disgrazia di restare sotto le macerie, non ha altro da fare che prendere la sua valigia e spostarsi un po’ più in là. In viaggio si sta bene perché, a parte qualche sciagura, terremoto o disastro aereo, non può veramente accaderci nulla; non si mette in gioco la propria vita. Il viaggio è anche una benevola noia, una protettrice insignificanza. L’avventura più rischiosa, difficile e seducente si svolge a casa; è là che si gioca la vita, la capacità o incapacità di amare e di costruire, di avere e dare felicità, di crescere con coraggio o rattrappirsi nella paura; è là che ci si mette a rischio. La casa non è un idillio; è lo spazio dell’esistenza concreta e dunque esposta al conflitto, al malinteso, all’errore, alla sopraffazione e all’aridità, al naufragio. Per questo essa è il luogo centrale della vita, col suo bene e il suo male; il luogo della passione più forte, talora devastante – per la compagna e il compagno dei propri giorni, per i figli – e la passione coinvolge senza riguardi. Andare in giro per il mondo vuol dire pure riposarsi dall’intensità domestica, adagiarsi in piacevoli pause pantofolaie, lasciarsi andare passivamente – immoralmente, secondo Weininger – al fluire delle cose.» (da CLAUDIO MAGRIS, L’infinito viaggiare)
*
«Ci sono due famiglie di scrittori.
Una è quella dei grandi bugiardi, che disfano con la fantasia la trama del mondo e inventano di continuo la vita, coprendo il suo monotono brusio con le loro inesauribili favole e sfuggendo alla gabbia della realtà come il barone di Münchhausen a cavalcioni della sua palla di cannone.
L’altra comprende gli agrimensori del reale, i naviganti che stendono mappe fedeli del cielo e delle coste, i poeti curiosi delle cose e dei destini, affascinati dalle storie che la vita, più imprevedibile di ogni immaginazione, scrive nei lineamenti e nelle vicende quotidiane degli uomini. Sedotti dal sanguigno piacere dell’esistenza e pervasi da pietas per il suo inarrestabile svanire nel tempo, questi scrittori vanno a caccia di storie vere, di vite vissute, con un rispetto per la realtà che li induce a citare fedelmente non solo i particolari di una rivoluzione o il numero esatto delle vittime di un naufragio, ma anche la luce di un pomeriggio, il colore di una foglia o l’espressione di un viso. Narrare diventa allora un’arte di montaggio, di lavorare con gli spezzoni offerti dal reale e di ricrearli in un ordine che ne riveli il significato nascosto. Se ogni vita, come vuole il detto popolare, è un romanzo, essi lo scrivono o meglio lo trascrivono». (CLAUDIO MAGRIS)
*
FRANCO TAVERNA, Avamposti. Exodus e le nuove frontiere sociali, EDIZIONI SAN PAOLO
*

